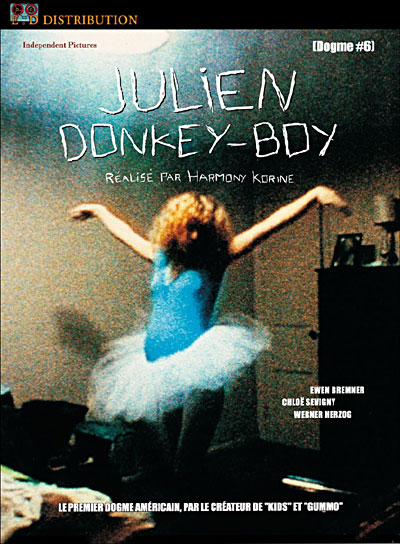A dispetto di quanto si possa pensare, 30 giorni di buio non è un brutto film. Tratto da una serie di fumetti scritti da Steve Niles e disegnati dall'artista Ben Templesmith (già disegnatore della serie Hellspawn), il film racconta di una cittadina sperduta nell'Alaska che, ogni anno, affronta un mese di notte continua. In quell'occasione alcuni terribili vampiri approfittano della situazione per fare una strage. I pochi sopravvissuti tenteranno di resistere fino all'alba. Girato da David Slade e con la bella fotografia di Jo Willems, che satura i colori per meglio contrastarli con il bianco della neve (c'è chi vi ha visto riferimenti ai quadri di Bacon), la pellicola non rappresenta alcuna novità nell'ambito horror-vampiresco. Persino l'ambientazione nordica ha già trovato migliori risultati altrove (La Cosa di Carpenter e The Last Winter di Larry Fessenden). Ciò che più ci interessa è la volontà di dar corpo all'ennesima contaminazione di generi, che sembra ormai  rappresentare il futuro dei cosiddetti film di genere. All'interno di un apparato horror, 30 giorni di buio gode di una struttura interna che richiama esplicitamente il western: una cittadina isolata, il vuoto del ghiaccio che sembra quello del deserto, l'attacco dei pellerossa/vampiri, le costruzioni delle case (che ricordano quelle di molti western). Addirittura si arriva al confronto finale tra lo sceriffo e il capo dei cattivi. In pochi hanno colto questi riferimenti metatestuali, che di fatto rappresentano i tratti di maggior rilievo del film. Oltre a questo, stupisce la scelta di rinunciare per buona parte agli effetti digitali per tornare al buon vecchio make-up, così come risultano essere interessanti alcuni momeni registici che, paradossalmente, sono essere tragicamente classici: una ripresa dall'alto della strage e la sequenza finale dell'alba, intrisa di un dolente romanticismo.
rappresentare il futuro dei cosiddetti film di genere. All'interno di un apparato horror, 30 giorni di buio gode di una struttura interna che richiama esplicitamente il western: una cittadina isolata, il vuoto del ghiaccio che sembra quello del deserto, l'attacco dei pellerossa/vampiri, le costruzioni delle case (che ricordano quelle di molti western). Addirittura si arriva al confronto finale tra lo sceriffo e il capo dei cattivi. In pochi hanno colto questi riferimenti metatestuali, che di fatto rappresentano i tratti di maggior rilievo del film. Oltre a questo, stupisce la scelta di rinunciare per buona parte agli effetti digitali per tornare al buon vecchio make-up, così come risultano essere interessanti alcuni momeni registici che, paradossalmente, sono essere tragicamente classici: una ripresa dall'alto della strage e la sequenza finale dell'alba, intrisa di un dolente romanticismo.
 rappresentare il futuro dei cosiddetti film di genere. All'interno di un apparato horror, 30 giorni di buio gode di una struttura interna che richiama esplicitamente il western: una cittadina isolata, il vuoto del ghiaccio che sembra quello del deserto, l'attacco dei pellerossa/vampiri, le costruzioni delle case (che ricordano quelle di molti western). Addirittura si arriva al confronto finale tra lo sceriffo e il capo dei cattivi. In pochi hanno colto questi riferimenti metatestuali, che di fatto rappresentano i tratti di maggior rilievo del film. Oltre a questo, stupisce la scelta di rinunciare per buona parte agli effetti digitali per tornare al buon vecchio make-up, così come risultano essere interessanti alcuni momeni registici che, paradossalmente, sono essere tragicamente classici: una ripresa dall'alto della strage e la sequenza finale dell'alba, intrisa di un dolente romanticismo.
rappresentare il futuro dei cosiddetti film di genere. All'interno di un apparato horror, 30 giorni di buio gode di una struttura interna che richiama esplicitamente il western: una cittadina isolata, il vuoto del ghiaccio che sembra quello del deserto, l'attacco dei pellerossa/vampiri, le costruzioni delle case (che ricordano quelle di molti western). Addirittura si arriva al confronto finale tra lo sceriffo e il capo dei cattivi. In pochi hanno colto questi riferimenti metatestuali, che di fatto rappresentano i tratti di maggior rilievo del film. Oltre a questo, stupisce la scelta di rinunciare per buona parte agli effetti digitali per tornare al buon vecchio make-up, così come risultano essere interessanti alcuni momeni registici che, paradossalmente, sono essere tragicamente classici: una ripresa dall'alto della strage e la sequenza finale dell'alba, intrisa di un dolente romanticismo. a. f.
Show
0 Comments
prev